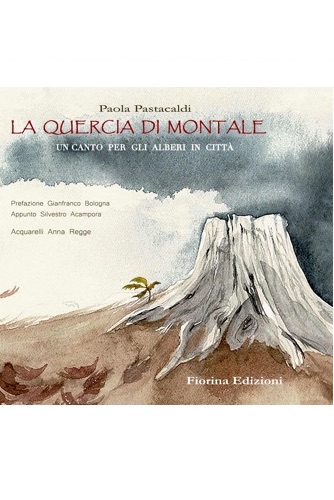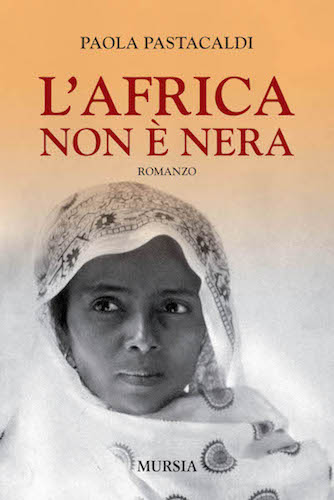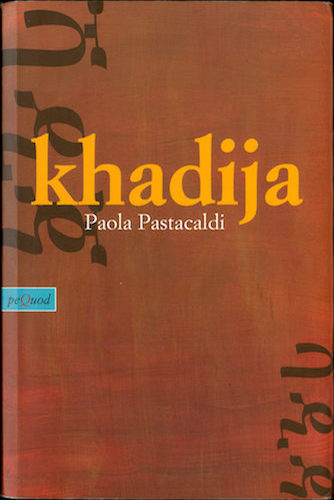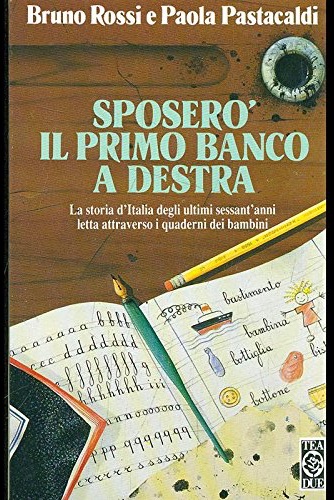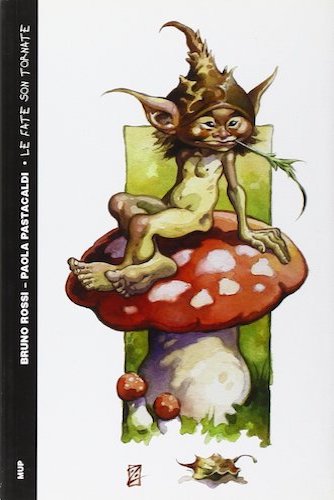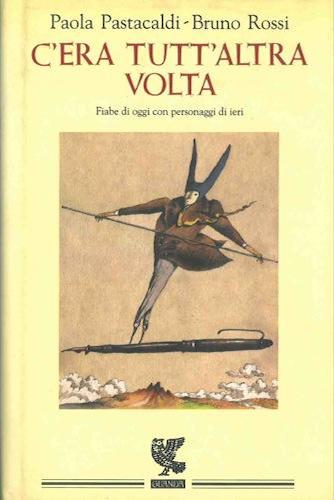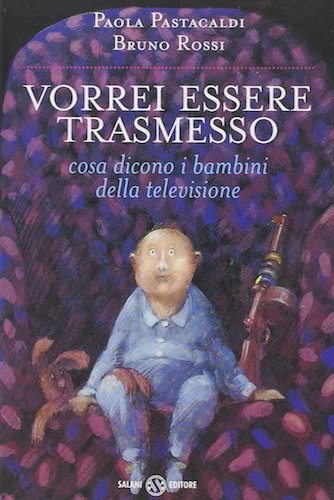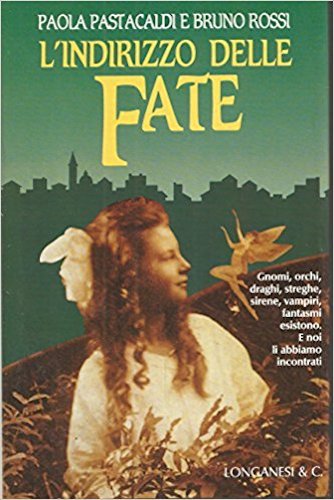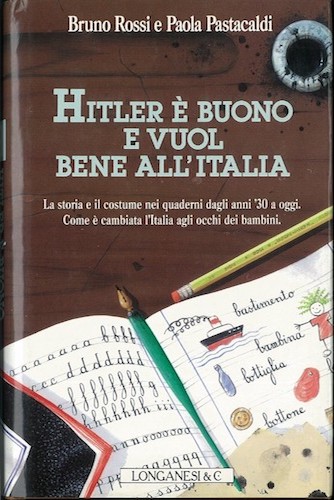'Il diario di un atto di coraggio'
di Marina Piazza, sociologa
Vorrei cominciare a ragionare sul libro di Paola Pastacaldi con le parole di Jane Campbell, una donna che ha scritto il suo primo libro “Spazzolare il gatto” a 80 anni: “Invecchiare è spesso descritto come un accumulo di malattie, sofferenze, rughe ma in realtà è un processo di espropriazione, di diritti, di rispetto, di desiderio, di tutte quelle cose che una volta possedevi e di cui godevi con tanta naturalezza”
E ancora: “Può esserci anche una certa pace e lo strano è che spesso deriva non da ciò che si è posseduto, ma da ciò che si lascia andare”.
Anche Paola Pastacaldi nel suo libro racconta della doppia espropriazione: del diritto di sua madre di morire e del suo diritto come figlia ad accompagnarla in questo percorso. E’ un diario che Paola scrive per condividere con se stessa il panico di fronte alla morte annunciata, ma senza scadenze di sua madre, è a se stessa che parla. Perché scrivere è un modo per rendere visibile quello che succede, prima di tutto a noi stesse. E per vivere questo dramma servono le parole giuste.
Il libro di Paola Pastacaldi è un diario senza date dove; mano a mano che la malattia procede, si susseguono percezioni, stati d’animo, sentimenti, che potrebbero anche essere letti come stazioni di una via crucis.
Provo a nominarle, poi torneremo sui singoli passaggi.
La prima stazione è la percezione della solitudine del curante, l’impossibilità di trovare risposte alle sue domande e l’indignazione che provoca questo silenzio: ”Non ci sono dati, pensieri, riflessioni, valutazioni: considerando che siamo un popolo di anziani, mi sembra incomprensibile”.
La secondo stazione è la negazione, il rifiuto di vedere la realtà. L’incapacità di ammettere la tempesta che si è abbattuta sulla madre e su di lei: “Mia madre, seduta sulla sedia a rotelle, così smagrita, così dipendente, con il suo corpo piegato dal digiuno e dalle medicine…è un’immagine che non mi appartiene”.
La terza stazione, dopo che la madre è stata ricoverata in ospedale, è la presa in diretta dell’orrore che l’ospedale riserva agli ultimi, a quelli tenuti in vita artificialmente, in attesa che arrivi la morte.
La quarta stazione è la rimozione del presente e del ricordo della persona che era sua madre con la sua forza e la sua voglia di vivere. Nel magma denso della sofferenza e della paura si aprono improvvisamente spiragli di ricordi con le immagini della madre giovane, viva, attiva.
La quinta stazione è il processo di identificazione con la sofferenza e la disperazione della madre (“ero io al suo posto…”). E questa identificazione la spinge, in un certo senso la costringe, a prendere la decisione di riportarla a casa, rispettando la sua volontà.
La sesta stazione è la sensazione di paura di fronte alla responsabilità che ha preso sulle sue spalle, la paura concreta della morte che verrà, di come affrontarla, dei sussidi necessari per assisterla, delle decisioni da prendere: “Che accadrà se non prende il diuretico? Se si sente soffocare?”
La settima stazione è la terra di confine, la difficoltà quotidiana di gestire questa paura in solitudine. Non ci sono parenti che la supportano, anzi potrebbero incolparla di qualcosa. Ma ci sono presenze “altre” a rendere meno compatta questa solitudine. C’è la badante ucraina, così capace di esserle vicina, con il suo rispetto per la vita umana, un rispetto antico di cui dolore e pazienza sono parti integranti. E c’è il medico amico. Presenze essenziali, benefiche, solidali con la vita, anche se la morte è ormai vicina, perché portano anche alla consapevolezza che “lasciar morire una persona, accettare la morte non significa ucciderla, ma accogliere ciò che deve accadere”.
E, infine, l’ultima stazione dove si fa lentamente spazio la compassione, la tenerezza di condividere con la madre questo ultimo pezzo di vita. Gli abbracci, i baci: “Uccido la mia paura con la tenerezza. Uso la tenerezza con un impeto furioso, marcio decisa, senza fermarmi” . Lenta, arriva la fine.
Ecco, queste mi sono sembrate le stazioni di un calvario che Paola Pastacadi ha voluto condividere con noi. Ma questa minuziosa e impietosa analisi non resta una cronaca, non si ferma ad un diario. E’ un atto di coraggio che è basato sul desiderio di ancorare la propria storia a una storia collettiva, a proporne uno spicchio fatto anche di discontinuità, di divergenze, di contraddizioni, nel tentativo di fare della narrazione - che all’inizio è rivolta solo a se stessa - una storia in cui tutte possiamo riconoscerci. Il diario, nato dalla paura di come può essere l’estrema vecchiaia, dalla solitudine del morente alla solitudine del curante, si trasforma in una riflessione a tutto campo, perché Paola Pastacaldi trova le parole giuste per coinvolgerci.
E’ in qualche modo una pratica di relazione, vuole essere ed è uno stimolo a una riflessione più ampia, un messaggio rispetto a una presa di posizione che invita alla condivisione di fronte all’enorme problema dell’invecchiamento della popolazione, soprattutto delle donne, con cui si confronta oggi la società italiana. Nell’assordante silenzio delle politiche pubbliche. E della scienza medica.
In qualche modo ci dice che, se nella morte ognuno entra da solo, è bene che qualcuno ti accompagni alla porta.
MARINA PIAZZA. Sociologa. Si è occupata dell'analisi delle soggettività femminili e delle loro trasformazioni, sia in ambito lavorativo che familiare. Negli ultimi anni si è dedicata prevalentemente al tema dei passaggi nel corso di vita delle donne. Ha scritto sul passaggio d’età dei cinquant’anni , dei trent’anni e attualmente della vecchiaia. Ha pubblicato nel 2019 La vita lunga delle donne, ed. Solferino.